Martedì sera, dopo l’ormai solita
partita di calcetto, mi sentivo abbastanza scarico e rilassato da potermi
giocare un Bergman. Era da parecchi mesi che non vedevo un’opera di questa
icona della Settima e non me l’ero mai sentita di recensirne una, ma, a sto
nuovo giro, ho deciso di buttarmi. “Come
in uno specchio” è stato un altro splendido viaggio di follia e angoscia made in Sweden. Pellicola che inaugura la cosiddetta trilogia
"religiosa" di Ingmar Bergman, dove il regista si addentra in
profondità nei meandri del "problema religioso", vincitore del premio
Oscar come miglior film straniero nel 1961… E si parte…
La cinepresa del genio svedese
mostra il pianto disperato di un padre, regalando il primo momento di pathos che, da questo istante in poi,
rimarrà costante per tutta la pellicola. Il pepe dell’opera.
L’amore di un padre, di un
fratello e di un marito è troppo forte perché la ragione possa prendere il
sopravvento di fronte alle sofferenze della loro piccola Karin (Harriet
Andersson che offre una straordinaria performance,
capace di cambiare umore, identità e stato d'animo ogni due secondi). Non vi
può essere alcuna spiegazione logica e razionale di fronte a quella
inaspettata, “stravagante” e ingiusta malattia, come non esiste qualcosa o
qualcuno che possa spiegare il perché di tanto strazio. I viaggi nel “l’altro
mondo” della schizofrenica protagonista si intrecciano con le riflessioni
religiose dei suoi cari. Dio come unica fonte di sollievo. “Non so se l'amore
dimostri l'esistenza di Dio oppure se l'amore sia Dio stesso…”, parole che regalano
un senso di pace, affascinanti, meritevoli di riflessione anche da parte di un ateo
radicalmente convinto. Attraverso quest’opera non ci si interroga
sull’esistenza di Dio, nella quale si crede fermamente, bensì si cerca di
dimostrarla, indagandone l’essenza.
Da un punto di vista stilistico,
mi ha impressionato la ricercatezza delle immagini del regista che non compie
grandi evoluzioni di zoomate, carrellate, inquadrature a spalla, “stacchi” d’immagini
e robe del genere, o magari anche, ma il massimo momento di goduria dei miei
sensi da cinefilo me li ha offerti in quelle scene per le quali ha piazzato la cinepresa su
un cavalletto, dipingendo il meraviglioso quadro che aveva in testa, del quale poi,
dirigendo i suoi attori come su un palcoscenico, ne creava i personaggi,
dandogli vita e sapienza. Mi hanno colpito i dialoghi sempre pungenti e
forbiti: mai una parola di troppo o una di meno e mai una grezza o errata. Un
altro “trattato su pellicola”.
Concludendo, mi faccio un puccetto d’umiltà e affermo che forse
non sono ancora in grado di recensire degnamente un capolavoro di un’icona
della Settima, ma dopo questo primo anno e mezzo da ‘rofumante posso sicuramente
riconoscerlo, apprezzarlo e quindi consigliarlo.
(Ste Bubu)


















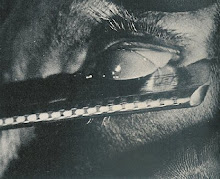



Azz. Ieri sera, all'"Oberdan", hanno seguito le tue indicazioni, Bubu, e hanno proiettato questo Bergman tosto, nelle sue vesti più teatrali e cerebrali.
RispondiEliminaPersonalmente, ho trovato le parole pronunciate in questo film tutta'altro che pacificanti e, spesso, una di troppo o una di meno. Detto ciò, lo squarcio che è in grado di aprire è, al solito, profondo e destabilizzante. Siamo tutti in equilibrio precario e, più che Dio, solo un affetto privo di ogni sovrastruttura o zavorra ideologica (un presunto successo artistico, idee preconfezionate attorno alle proprie pulsioni) può renderci presenti, qui. Arte e vita, già, possono confondere, figurarsi ad aggiungerci divinità e ragni.
Girato dopo "Il posto...", ne conserva il rammarico del tempo passato senza coscienza. Molto soffocato e rabbioso, però, questo non ne ripropone la brezza dei dolci-amari ricordi che, d'altro canto, potrebbero portare ad una benefica riflessione su di sé. Didascalico, pure, perché nonostante si tratti di specchio che rimandi ad altro "Io" tenacemente ignorato, quindi senza alcuna pretesa di spiegazione, bensì riflessione, rappresentazione, questa sul finire si faccia un po' noiosetta...
Bub