Venerdì scorso, dopo il concertino a "La Claque", del cantautore corso Stephane Casalta, e il solito girongiro per le "Erbe", entro in sala Negri con l'intento di scartare una gloriosa VHS. Strana soddisfazione nell'appiccicare l'etichetta adesiva e inserire la scatola nera in un'altra più grossa! Il film in programma è un cult generazionale: "Soldato blu", dello statunitense Ralph Nelson, pellicola del 1970, volle riporre in luce uno dei tanti massacri perpetrati dall'esercito yankee contro gli Indiani d'America. Colpendo nel segno, a sorpresa, a tempo quasi scaduto, tramite immagini truci di grande impatto.
L'intento del film è dichiarato sin dai titoli di testa, a suon di canzone dedicata e didascalia ("La cosa più raccapricciante è che certi fatti siano realmente accaduti"). Poi inizia il racconto, tratto da un romanzo e assumendone le vesti. Sceneggiatura semplice, che poggia quasi interamente sulla bellezza disarmante della protagonista, algida sì, ma ripiena di diavolina, cosparsa di salsa barbecue. Candice Bergen (figlia di papà hippie , fiamma-moglie di Louis Malle), nei panni della super bionda sveglia e alla mano, va a spasso col soldatello sfigato ma ligio (Peter Strauss). Poi indiani tenaci ma leali. Bianchi i veri sanguinari, non come dicono i libri (e tanti altri film).
Film che, nel 1970 e nelle sua piazze in rivolta, trovò humus fertile per saltare di bocca in bocca (riferimenti al conflitto vietnamita furono automatici, in particolare al massacro di "Mỹ Lai", del marzo 1968); ma che, come già detto, punta quasi tutto sul corpo di "Kathy" Bergen, in grado di accalappiare l'attenzione dello spettatore alla minima distrazione, dalla sua comparsa, tutta imbacuccata, sino alla fine, coperta da uno straccio; quando, davvero, "non era mai stata così bella" (altro che serpente...).
Ma è una pellicola che il fianco lo espone: per almeno tre quarti della durata, in cui l'impostazione è quella della commedia rosa leggera (quasi disneyana), con un buon ritmo, senza addentrarsi mai nelle tenebre dei protagonisti e in cui fioccano le gag slapstick e le battute facili ("Lavora a secco!"), i bronci e i sorrisi. A spezzare questa monotonia narrativa, la parte conclusiva, che disintegra totalmente il tòpos del lieto fine.
D'altronde, è impossibile stare dalla parte dei visi pallidi: in un crescendo di violenza (l'attacco all'accampamento indiano a Sand Creek, con bambini travolti, decapitazioni, stupri e asportazioni di seni e altro), gli autori raggiungono l'effetto desiderato, shock, indignazione e rabbia. Ma non solo perché quel massacro (così come tutti gli altri avvenuti e che verranno) non avrebbe dovuto essere, ma perché pare evidente il disequilibrio della pellicola, tra quegli ultimi e fragorosi momenti (meno di 20 minuti) e tutti i prcedenti. Tutti risvegliati bruscamente, quindi: coscienze sempre intorpidite e spettatori ormai rassegnati. Giusta e condivisibile la volontà di ribaltare l'usurato schema manicheo del cowboy buono aggredito dall'indiano crudele, ma il risultato non ha la compattezza del film di qualità. Ripeto, lo scarto d'accento è troppo lampante
"La posizione del governo è che stiamo in Vietnam per onorare un impegno. Non dimentichiamoci però che abbiamo stipulato 400 trattati con gli indiani, violandoli tutti, uno dopo l'altro.", eccole le significative parole del regista, che il mondo militare lo conosceva bene, avendovi prestato servizio.
Agli Indiani d'America, sterminati dagli yankee (questo sì, un genocidio); contro tutti gli americani inconsapevoli, colpevoli. Contro ogni guerra.
(depa)


















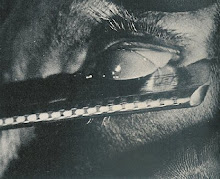



Nessun commento:
Posta un commento