Recuperato in extremis l'ultimo papabile nelle sale italiane. Film tedesco, Elena ed io di corsa verso quella presentata come una storia d'amore; intensa come un grido, uno sguardo, come un film che rimane in mente? Purtroppo, in "Undine" (in italiano, irrobustito da "Un amore per sempre"), il grido non c'è, lo sguardo sì, ma resta fermo. L'ultimo lavoro del renano classe 1960 Christian Petzold, se verrà ricordato, lo farà per il rammarico di una passione lasciata scappare.
Peccato mortale, con un incipit che per intensità è quasi memorabile (ma sarebbe dovuto iniziare col nome della protagonista sulle prime labbra del carnefice!). Un'agghiacciante passeggiata sovrastata da un pianoforte di dolore, che tornerà e tornerà. Poi una regia che ben avvolge questo soggetto doloroso e mellifluo. Soggetto tragicamente perfettibile. I momenti smaccatamente allestiti (la scena clou dell'acquario, come gli stessi dialoghi al tavolino del bar; o le suggestive lezioni di storia urbanistica, lunga metafora del film), non conducono alle altezze attese. Le allucinate sequenze subacquee avrebbero convinto senza scritte sui muri (sommersi), con tanto di cuore. L'incombente rumore del metrò irrompe, e irromperà, tra le suddette note di piano. Gli squilli della distanza, le segreterie dell'abbandono. "Non stavo dormendo", dialoghi da rivedere. Eppure pesano. "Non stavo aspettando lui, ma attendevo te da tutta la vita". Zio fa. Bacio sul binario, poi mano sul vetro, quindi rincorsa del treno. Forse un po' troppo. Mi dico: deve per forza arrivare un meteorite (altro che "8 ettari e 1200 stanze"), iperbole che domo nel rivolgermi ad Elena: "Ora però deve saltare tutto". E botto sarà, multiplo, in sordina anch'esso. Ecco: un film che parte in quarta e vi rimane.
Con le debite, troppe le donne dai carismi ben più fascinosi apparse nelle ultime sale. Nuove guerrigliere urbane, spagnole infuocate, algerine incazzate, saudite determinate. La povera Undine Wibeau s'eclissa. I suoi silenzi lasciano il tempo. Non certo per colpa di Paula Beer, qui vincitrice alla 70a Berlinale, rosa rossa perfetta, tra i rampicanti cupi muri a vista. Avant'indré, museo-casa, baretto-museo. Il pendolo dell'amore non brilla per originalità, certo, ma quante spine del gran cinema trascorso sgorgano dolore ancora vivo?
Il finale poi...Quanto meno due degli otto spettatori della Sala 2 si sono detti che, tanto valeva, chiudere su un altro plateale suicidio d'amore. Inspiegabile il lieto fine amniotico di questo "Atalanten" ambizioso, con statuetta dolce-ricordo annessa. Elegia d'amore, ma sommessa.
(depa)


















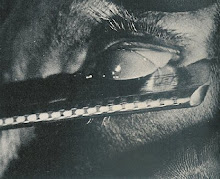



Nessun commento:
Posta un commento