Ieri sera nella "Valéry" è tornato Akira Kurosawa. Il regista la cui arte fondeva maestosamente Poesia ed Azione, ha portato con sé "L'angelo ubriaco", pellicola del 1948 che, ancora una volta, ha emozionato la sala con eleganza e ritmo. Elena, Juri (novità!) ed io, a contemplare questa Settantenne più che mai moderna.
Carrellata iniziale e son già a rischio polluzione. La musica introduce perfetta i volti espressionistici e la girandola dei contrasti inizia a roteare, con ritmo vorticoso ma ipnotizzante: una goduria.
Nell'intreccio noir che avvince (siamo in "pura" Hollywood), s'innesta la maestria del regista nel muoversi in spazi ristretti e di giocare con luci ed ombre (affascinanti sequenze del mercato). Altri contrasti, insomma, a significare che tra bene e male le cose non vanno un gran che bene. Ad esaltare un attrito, anche visivo: il viso angelico della giovane paziente in via di guarigione viene posto con montaggio astuto a pochi centimetri dal volto rude del medico.
La cloaca attraversata ripetutamente dalla m.d.p. è simbolo di luogo impossibile da sanare, mefistofelico scenario di un'umanità già in putrefazione. Le metafore di Kurosawa vengono quasi sempre smascherate, come a dire "nessun bluff, intrattenimento per tutti". E anche questa verrà ribadita dalle parole e dalle immagini, coll'indimenticabile sequenza dell'incubo premonitore: due carrellate in sovrapposizione, il primo Io, troppo tardi risvegliato, è inseguito da quello già condannato (uno è vestito di bianco, l'altro di nero). Il paesaggio più che mai connesso ai suoi brulicanti. In quel luogo angusto, intenso e inevacuabile, scorgiamo qualche baracca, un angolino da sonata (dove si svolge la breve, bellissima ed efficace, sequenza del "cambio alla chitarra"). Scenografie di cui ci si può innamorare (la sequenza in cui Matsunaga arriva ubriaco al club, il suo strascicare lungo enormi carte da gioco appese). Ricordano scene da gran cinema americano. Kurosawa prende spunto e ci mette del proprio (superando?).
Grandiose interpretazioni. Su tutte quelle dei due protagonisti, in perenne lotta disperata, Takashi Shimura e Toshiro Mifune (il primo già noto al regista, il secondo esordiente che diverrà feticcio). In bocca loro, i dialoghi, che son lame acute ed efficaci ("Solo i malati e i bambini non hanno orgoglio"), aiutano la pallina a stare sopra il soffio della tensione (colgo l'occasione, inoltre, per plaudere all'ottimo lavoro in fase di doppiaggio).
Un film mostra il proprio spessore anche con lo spettro delle riflessioni che offre. In questo caso, è affascinante il rapporto tra medico e paziente, ribaltato continuamente nella logica del gangstar/dottore. E' anche il film delle difficili assoluzioni, dei ma; degli uomini d'un pezzo ma privi di qualche frammento. Integerrimi col vizietto. Uno è medico dedito al mestiere, ma beve; l'altro pare imbattibile, ma ha un tallone nei polmoni.
Alla fine della proiezione, tutti e tre in sala soddisfatti (a parte la perplessità di Elena: "Ma perché voleva aiutarlo?!", fosse facile spiegare cosa spinge un medico ad aprire mani, rischiare e raschiare carne, lo sarebbe ugualmente spiegare perché è così difficile dire "no"...).
Lo riguarderei altre quindici volte. Facciamo che "ripieghiamo" su altri Kurosawa?
A presto 'Rofum.
(depa)


















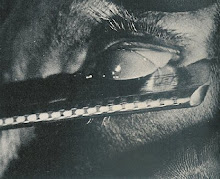



Nessun commento:
Posta un commento