Altro venerdì, altro film. Chissà quando diverrà un automatismo, una sorta di luogo comune, assodato e vero. Questa volta la scelta, che ha coinvolto ancora lo sfortunato, si fa per dire, Mino, è caduta sul nome di Debra Granik, regista statunitense che si fece pulce e mise nido nei miei padiglioni (causa suggerimento familiare di otto anni fa). "Senza lasciare traccia" parte ottimamente, colla determinazione di chi vuol davvero indicare una diversa direzione, lontanissima dalla società del consumo e del spettacolo, più aderente alla natura che ci apparterrebbe. Ma infine chiude come se pensare ed agire differenti siano segni inequivocabili d'una follia. E allora viene da dire "cosa l'ho visto a fare?".
Ovviamente il mio discorso rimane sul piano contenutistico, dove le mie friggitorie cerebrali son sempre all'opera; per quanto riguarda la mise-en-scène, poco da dire alla Granik, alla quale va riconosciuta la capacità di pedinare i propri protagonisti, senza perderne le tracce, appunto, e cogliendone le tensioni interne e nel rapporto padre-figlia.
Ripeto, quando pensavo che si potesse essere davanti ad un nuovo film culto cui naturalisti, primitivisti, anti-capitalisti in generale potessero volgersi con soddisfazione, il tutto viene ridotto ad un caso di ossessione, di paranoia, di incapacità agorafobica, senza capire che non c'è alcun bisogno di aver fatto il Vietnam per essere schifati dalla società. Nel momento in cui le istituzioni, nelle figure qui di amorevoli assistenti sociali, mostravano tutta la loro vuota retorica fatta di comodità e relazioni spicce, è emerso che, per gli autori, questa fosse davvero una cura, magari dolorosa, pur necessaria. Il momento critico è quello in cui la ragazza si ritrova a scuola a scoprire di essere un animale sociale, dando il via agli indugi col padre. Un po' brusco per una figlia che, pochi fotogrammi prima, stava a metà tra Tarzan e Predator. Peccato per me, Debra, pensavo d'aver trovato un'amica.
(depa)


















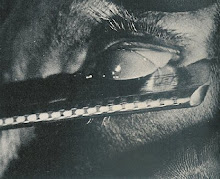



Nessun commento:
Posta un commento