Venerdì scorso, al "City" di Genova, ho rotto il patto stretto con me stesso: vedere un film contemporaneo italiano. Per "Cesare deve morire" dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani, ottima pellicola del 2012, fresca vincintrice dell'Orso d'Oro. Dopo aver visto alcune immagini del film in televisione e ascoltando le interviste ai "due registi in uno" di San Miniato, si entra in sala senza esitazione, il bianco e nero degli spezzoni divulgati, già di per sé, addita profondità e valore artistico del film; che finisce con l'affascinare il cinefilo, nel sapere dell'utilizzo, non di attori professionisti, bensì di uomini detenuti in carcere di massima sicurezza.
Ed è proprio questo, anche, il rischio più grande corso dai due registi più che ottantenni: il cadere in una produzione più "assistenzialistica-solidale" che artistica, volta maggiormente a scuotere animi pietrificati dalla vita piuttostoché appassionati della Settima (il che, ovviamente, non sarebbe un fine esecrabile, ma nemmeno strettamente cinematografico). Le immagini dei Taviani (in particolare Vittorio, il maggiore) che, alla consegna del sommo premio della Berlinale, si commuovono nel dedicare il successo a quelle persone che non possono essere lì con loro né da nessun'altra parte, potevano suggerire un bieco tentativo di far parlare di sé attraverso vie alternative. Ma quelle parole e quella commozione erano troppo pesate e autentiche, per sottendere un banale artifizio commerciale, il messaggio troppo lucido.
Quindi, io e mia madre siamo entrati senza troppa vergogna per il suddetto patto infranto. E, forse, è proprio il fatto che gli attori non siano usciti dalle accademie dello spettacolo a rappresentare una sorta di marchio di garanzia... Tant'è che non ci si è sbagliati: le interpretazioni lasciano a bocca aperta. I volti si fanno vere e proprie maschere teatrali riconducibili istantaneamente ai concetti di onore, tradimento, potere, infamia, morte...Bruto e Cesare sono da applausi.
Il film è leggero nella struttura e nello svolgimento, lasciando che il pubblico si possa dedicare interamente alle espressioni degli attori e a ciò che sottendono, sia nel film (in Shakespare), sia nella vita (nostra e dei detenuti). I piani molteplici risultano narrati splendidamente senza ingarbugliamenti né facilonerie. Personalmente, a tutta la pellicola avrei sottratto soltanto il rapido elenco delle condanne, solo perché ritengo non fosse strettamente necessario (che non siano degli stinchi di santo e che non passino le giornate a giocare nel campetto del carcere è lampante), ma si tratta di un dettaglio trasurabile che non appesantisce la narrazione e che, anzi, può essere compreso (sottolineatura che metta in contrasto l'avventura artistica, conclusa con successo, a prescindere, con quella personale, dal finale realmente tragico).
Il successo del film dev'essere attribuito non solo, quindi, alla profondità delle interpretazioni, ma anche all'abilità dei due registi della provincia di Pisa nel non "cadere", non percorrere la sdolcinata scorciatoia già battuta e allestita dalla nostra "viva" società; cosa che, in un'opera cinematografica come questa, è una sorta di miracolo. Complimenti ai Taviani, fischi a chi relega questo film a pochi giorni di proiezione in sale nascoste al grande pubblico, mettendo così in atto il più grave torto possibile al "padre, fratello, figlio" dei due fratelli registi toscani: William Shakespeare. Impossibile che la società si elevi con gli ultimi capolavori di C. Verdone.
(depa)


















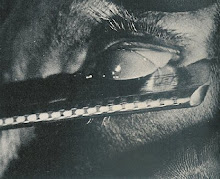



Nessun commento:
Posta un commento