Appena usciti dalla sala Fedra in cui, io ed Elena, abbiamo visto l'ultimo lavoro di Lars von Trier: "Melancholia" è uscito quest'anno, presentato al festival di Venezia 2011. Il regista danese continua il suo percorso, macete in mano e anfibi ai piedi, verso un cinema inesplorato e, dopo aver distrutto il musical che racconta balle zuccherine, dopo aver dimostrato che il cinema può dimenticarsi dell'ambientazione ricercata inquadrando “solo” parole e sentimenti, tira la freccia ancora più lontano, azzarda di più e ci consegna un film esistenziale: follia, inquietudine, paura, natura, vita, morte.
In questo film compaiono temi gravi, ma il risultato è un'armoniosa sinfonia, a parer mio. Inizia con immagini digitali fantasiose, oniriche (bellissime tra l'altro, vero Malick?), in cui lo spettatore, in verità, potrebbe preoccuparsi, nonostante sappia bene con chi ha a che fare. Poi compaiono nome del regista e titolo, e von Trier ci mostra una volta di più che sa cogliere con la cinepresa amore, vita e follia come pochi altri. Danza per tutto il film sul filo dell'equilibrista che di qua precipiterebbe in un abisso di assurdità, di là si schianterebbe su scogli di appuntita banalità. Prima parte alla follia, quella più profonda, quella più incomprensibile; Melancholia è la mancanza di un oggetto che dia senso alla nostra voglia di soffrire, è un male di vivere che non sa su cosa poggiare, precipitando. Seconda parte alla paura, della morte in questo caso; ma quel pianeta sta lì proprio, “aenorme”, a ricordare quanto sia piccolo il significato di questo terrore che attanaglia da sempre minuscoli omuncoli, diventa la summa di tutte le paure, inutili ma vere, hic et nunc mi viene da dire. Forse, la forza di questo film sta anche nel fatto che gli eventi non sono poi così fantascientifici. E quindi, tutti pronti ad aspettare il momento: il regista nel finale regala emozioni rare, ricordandoci, una volta di più, che sull'immortalità non devono e non possono investigare scienziati incamiciati tra provette e microscopi, bensì artisti in grado di alzarci per qualche minuto sul suolo da cui in realtà non ci staccheremo MAI.
Hollywood sempre più lontana e ridotta in calcinacci fumanti invisibili, nessuna megalopoli in preda al panico collettivo, nessun funghetto nucleare che si alza dalle varie capitali, solo spazi individuali, immense distanze come quelle che ci riempono, isolamenti inesplicabili che uniscono persone sempre a contatto, è questo un film riuscito sulla solitiudine totale e definitiva, dentro nel primo tempo, fuori nel secondo. Vietato parlare della fotografia, qui trampolino per catapultarsi in altro ("Shining" docet). La scena del ponte oltre il quale la Natura non s'azzarda e contro cui l'uomo (il progresso) sbatterà la testa inutilmente e dolorosamente è stupenda; la "grotta magica" che realmente sarà l'unico luogo sicuro prima della fine è un versetto delizioso.
Nessuna voce fuori campo perché la parola in quegli attimi è sovrastruttura che contamina e sporca, tutt'al più la “Wagner & Ludovico Van Band” (a proposito, lo sguardo del figlio mi ha ricordato l'"Alex" McDowell) quanto mai ammaliante e destabilizzante ad accompagnare l'avvicinarsi del buio, ovvero le luci in sala.
(depa)


















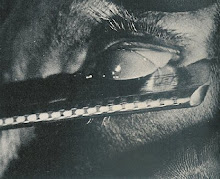



Caro Mereghetti,
RispondiEliminadeludente è, ancora una volta, la sua recensione-video sul Corriere (appunto): scialba, avvilente, un linguaggio da bambino alle prime parole (“castello”, “persino gli animali…”), riflessioni da bar, sprezzante superficialità...Ma che bella mandria di spiritosi sono questi critici italiani a cui qualche allocco paga ogni anno una decina di pagnotte, comprando i loro manuali che rattristano, fate vobis, innanzitutto per quei poveri alberi sacrificati al nulla, a quel buio che il maestro Mereghetti si permette di attribuire all’artista danese. Ancora peggio quelli in studio nella trasmissione di Marzullo su Rai 1, gente che riesce a cassare biecamente film come questi e a fare sorrisini di fronte a cagate come “Super”, che il fuoco del Nuovo cinema paradiso colga le vostre videoteche!!
Mereghetti prodotto da "Mai dire gol": il male di vivere non chiede spiegazioni ma di essere ascoltato!
A chi dice che i protagonisti "non restano dentro", "non sembrano indispensabili" dico che, questa, è la vera forza del film.
Io credo che in questo film il regista abbia voluto affrontare in modo più metaforico degli altri la resa dell’uomo alle malattie della psiche, volente o nolente.
RispondiEliminaLa prima parte ci dimostra come non ci sia nulla di tanto meraviglioso che possa attecchire la mente di una persona malata. Anche il giorno del matrimonio, che per una ragazza dovrebbe essere il più bello di tutta una vita, per la protagonista diventa un peso quasi insormontabile, e ce lo dimostra in varie occasioni (una fra tante il momento in cui porta il nipotino a dormire, un pretesto per potersi allontanare dalla festa). Oltretutto ci fa capire come non abbia nessuna importanza reale per lei la commemorazione di quel giorno, dalla scena della pipì nel giardino con l’abito della cerimonia (forse la cosa più preziosa per una sposa) al forse un po’ troppo forzato atto del rapporto sessuale con il primo essere maschile incontrato in quel momento durante la sua fuga... sicuramente la foto lasciata sul divano dello studio è un segnale ancora più forte della perdizione di Justine, della sua inadeguatezza nell’affrontare una vita con suo marito.
La seconda parte del film è più focalizzato sulla vita della sorella, sulle sue paure; vagamente diverse da quelle di Justine, ma legate dalla parola solitudine...la prima la sente dentro di sè, le mangia l’anima, la seconda è terrorizzata dall’idea di perdere la sua famiglia e le sue certezze. Proprio lei, una donna al’apparenza sicura di sè, amante del controllo sulle situazioni, che alla fine si lascerà guidare dalla sorella malata poichè si scoprirà del tutto inadeguata ad affrontare qualcosa più grande di lei. Ed è questo forse che vuole dirci il regista con questo film...la paura fa soccombere tutto e tutti. Il pianeta Melancholia altro non è che la rappresentazione metaforica del male di vivere, che può essere indistintamente paura, depressione, sconforto. I messaggi che si possono poi trarre dal rifiuto del cavallo ad oltrepassare il ponte, nonchè della macchina in un secondo momento, ci dicono che non vi è una via di fuga....ma si deve affrontare la realtà (come faranno i protagonisti alla fine del fim, tranne il marito che non aveva la forza nemmeno di supporlo, e si suicida).
Tanti i simbolismi di questo film...forse da rivedere subito per focalizzarli meglio. Le parole inquietanti di Justine, quando dice di sapere tutto, fondamentalmente spiegano anche il perchè dell’avvicinarsi di Melanchonia: il pianeta sta danzando con la terra, si allontana e si riavvicina, proprio come il male di vivere che attenaglia...ma la terra è un brutto posto dove stare, e questo “male” attira come una calamita il pianeta – simbolo.
All’inizio credo che le scene meravigliose del film (un po’ stile Tim Burton) altro non siano che le visioni di morte della protagonista, rappresentate in modo fiabesco, onirico ma allo stesso tempo cariche di una tragicità singolare...il tutto accompagnato da una colonna sonora idilliaca e perfetta. Da vedere, per uscire dalla sala con la sensazione di un risveglio.
"Acqua e farina" in realtà è Pollinz :D
RispondiElimina