Qualche giorno fa è venuto a salutare il Cinerofum, per la terza volta, uno dei pilastri della "Settima" hollywoodiana. Non soltanto, poiché John Ford s'è presentato con uno dei suoi film più celebrati e discussi. "Sentieri selvaggi", del 1956 (t.o. "The searchers", tratto dall'omonimo romanzo, di due anni prima, dello statunitense Alan Le May), in effetti pare realizzato a posta per provocare, compito grandiosamente impersonificato dal protagonista, John Wayne/Ethan Edwards. Dopotutto si tratta solo di affrontare con realismo il contesto del famigerato far west, non soltanto terra lontana di spettacolari paesaggi e leggendarie avventure, ma anche di violenze, massacri e vendette.
"Texas 1868" e, con una carrellata in avanti che è già storia, si esce allo scoperto: dal focolare caldo d'affetti al deserto cosparso di belve. Eccolo che arriva, lo zio scomparso da un po'...Riabbraccio singolare, altro che camino domestico, per essere tra parenti quasi dimenticati. Tipo strano questo Ethan, almeno per un classico personaggio da western. Questa sua complessità, una delle peculiarità che rese la pellicola unica. Anche senza rivedere il film, appare evidente che zio Ethan, John Wayne protagonista, è un incallito xenofobo (con le cause del caso, inscritte poi su una lapide consumata), affetto dal tipico individualismo americano di frontiera fine XIX secolo, quello proprio dei pionieri pronti a tutto, determinazione unica e proiettile impazzito. Inquieto, tenace e confuso, non patteggia con nessuno. "Non mi chiamare zio, né signore...mi chiamo Ethan". "Non voglio nessuno con me". Cinico, concreto ed esperto ("non c'è tempo per pregare, padre", "è il tuo funerale"), di gran lunga il più competente in battaglia, in amore con più in difficoltà. Da qui il fascino da Not conventional western della pellicola, con l'eroe redarguito dai compagni per l'eccessiva o gratuita brutalità.
Per il resto, sceneggiatura che quasi cammina da sola e panoramiche meravigliose su paesaggi mozzafiato e scenografie ricostruite con cura lampante e di grande effetto; come il celebre parossismo di luce rossa, al tramonto pre-massacro (che poi è una consueta vendetta), dove il regista orchestra perfettamente il ritmo di quell'atroce attesa. Momenti di splendida azione: l'affiancamento ed inseguimento subito dagli indiani; o le cariche di cavalleria negli accampamenti indiani. Attimi di estrema delicatezza e ricercatezza visiva (la comanche col cappello, coll'indimenticabile contrasto dei colori). Insomma, seppur in corsa e in perenne inseguimento, la pellicola è una catarsi per gli occhi.
Nella dinamica del racconto, da sottolineare la figura del reverendo-capitano Clayton, altalenante tra il politicantesimo più caciarone e l'interventismo da squadrista (facile notare che i sistemi di rappresentanza hanno fatto ben pochi passi avanti). Personaggi a contorno ben modellati (Mose...), gag classiche e consolidate (la caduta dalla panchina) immerse come per sfida in un film arditamente sui generis, amori traditi (quello, ancora una volta, tra il protagonista e la moglie del fratello: il loro primo sguardo, l'ultimo fatale bacio, sarà lei, la prima che chiamerà a massacro compiuto).
Bello quanto avvincente, immediato quanto complesso. Dovrebbe bastare per determinare un film che è meglio aver visto.
(depa)


















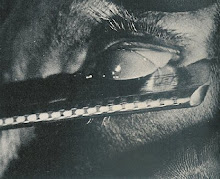



Nessun commento:
Posta un commento